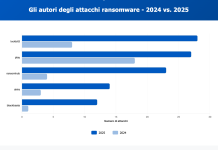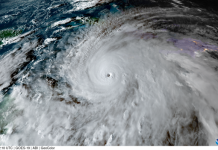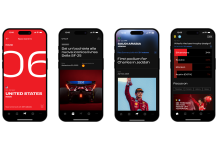Fino a poco tempo fa, l’intelligenza artificiale (IA) era, nell’immaginario delle persone comuni, un’idea affascinante ma relegata alla fantascienza – materia da romanzi e cinema.
Eppure, lontano dai riflettori, il suo sviluppo era già in corso da decenni: nelle università e nei laboratori delle grandi aziende, l’IA prendeva forma un passo alla volta.
Oggi, quella lunga e silenziosa evoluzione è uscita allo scoperto per entrare nelle nostre vite: interagiamo con soluzioni di IA decine di volte al giorno, spesso senza accorgercene, perché ormai integrate nei nostri dispositivi.
Cosa significa intelligenza artificiale?
Semplificando al massimo il concetto, l’IA è l’insieme delle tecnologie che mirano a insegnare a un sistema informatico a compiere azioni e a prendere decisioni, compiti che normalmente richiedono l’intelligenza di un essere umano.
In altre parole, l’obiettivo è fare in modo che i computer possano svolgere compiti specifici in modo “intelligente”.
Oggi questo obiettivo è diventato possibile grazie alla capacità delle tecnologie attuali di riconoscere schemi (pattern) in enormi quantità di dati e di usare tali schemi per fare una previsione o compiere un’azione utile.
Come siamo arrivati fino ad oggi? Un viaggio lungo oltre 70 anni
Il percorso dell’IA nasce in tempi in cui le tecnologie erano agli albori e non è stato una linea retta, ma un’avventura fatta di grandi sogni, successi, delusioni e ritorni.
Una delle pietre miliari fondamentali è senza ombra di dubbio il lavoro svolto dal matematico Alan Turing, che già nel 1950 si pose la domanda: “Le macchine potrebbero pensare?”.
Propose un esperimento, oggi da noi chiamato in suo onore “Test di Turing”: se una macchina avesse conversato con un umano senza che questo si accorgesse di non parlare con una persona, allora avremmo potuto considerarla intelligente.
Pochi anni dopo, nel 1956, il termine “Intelligenza Artificiale” nasce ufficialmente durante un convegno estivo al Dartmouth College, negli USA.
Un gruppo di scienziati si riunì con l’obiettivo ambizioso di insegnare alle macchine a usare il linguaggio e il ragionamento umano.
I primi programmi erano basati su liste di regole.
Un esempio famoso è ELIZA (1966), un primitivo “chatbot” che simulava uno psicoterapeuta.
Se scrivevi “Sono triste”, lui cercava la parola “triste” e rispondeva con una frase preimpostata come “Perché sei triste?”. Non capiva davvero, ma dava l’illusione di farlo. Questo approccio, chiamato IA Simbolica, consisteva nello scrivere regole rigide del tipo: “SE succede X, ALLORA fai Y”.
Le promesse, però, erano state troppo grandi e la tecnologia dell’epoca troppo limitata. I computer non erano abbastanza potenti e l’approccio a regole si rivelò inadatto a gestire la grande complessità del mondo reale. Di fronte ai pochi risultati, gli investimenti crollarono, dando inizio a periodi di forte disillusione chiamati “inverni dell’IA”.
L’IA tornò in auge intorno agli anni ’80 con i “sistemi esperti“. Erano software che immagazzinavano la conoscenza di un esperto umano in un campo specifico (ad esempio, le diagnosi mediche) per fornire consulenze. Questi programmi raggiunsero grandi risultati, ma la necessità di aggiornare continuamente le regole e i dati rese il loro mantenimento costoso e complicato. All’inizio degli anni ’90, anche questo filone entrò in crisi.
Il culmine di questa IA “basata su regole” fu raggiunto nel 1997, quando il supercomputer di IBM Deep Blue batté il campione del mondo di scacchi Garry Kasparov. Fu un evento epocale, ma Deep Blue vinse grazie a una smisurata potenza di calcolo, analizzando milioni di mosse al secondo, non perché “capiva” il gioco in modo intuitivo. Era evidente che questo tipo di approccio avesse pesanti limiti alla base.
Il Machine Learning
Di fronte agli evidenti limiti dell’IA Simbolica, molti ricercatori scelsero fin da subito di percorrere un’altra via. L’idea geniale fu: “E se invece di dargli le regole, gli facessimo “vedere” tantissimi di esempi e lasciassimo che sia lui a capirle da solo?”. Questo è il cuore del Machine Learning, o “apprendimento automatico”.
Come funziona, in pratica? L’analogia perfetta è il modo in cui impara un bambino. Per insegnargli cos’è un cane, non gli facciamo un elenco di regole. Se dicessimo “ha la coda e quattro zampe”, saremmo costretti a creare un’infinità di eccezioni per non confonderlo con un gatto o altro. Invece, gli indichiamo tanti cani diversi dicendo “guarda, un cane!”. Dopo averne visti abbastanza, il cervello del bambino “impara” il modello e sarà in grado di riconoscere un cane che non ha mai visto prima.
L’idea di una macchina che impara da sola ha radici profonde, quasi parallele a quelle dell’IA simbolica. Uno dei primissimi esempi risale al 1959, quando lo scienziato Arthur Samuel creò un programma per giocare a dama che, partita dopo partita, diventava sempre più bravo perché imparava dai propri errori. Fu proprio lui a coniare il termine “Machine Learning“. Nello stesso periodo, Frank Rosenblatt creò il Perceptron, un primo, rudimentale “neurone artificiale” che poteva imparare a riconoscere semplici schemi.
Tuttavia, come per l’IA Simbolica, mancavano gli ingredienti fondamentali: una grande quantità di dati da cui imparare e la potenza di calcolo necessaria per analizzarli.
Il primo vero assaggio del potenziale del Machine Learning si ebbe negli anni ’90. L’aumento della potenza dei computer rese infatti possibili compiti come il riconoscimento della scrittura manuale (sui primi computer palmari) o, cosa che oggi diamo per scontata, il filtraggio delle prime e-mail di spam. Questi successi prepararono il terreno, dimostrando che l’approccio basato sui dati era la strada giusta.
Da qui, l’apprendimento automatico si è diversificato in diversi approcci:
- Apprendimento Supervisionato: I programmatori “supervisionano” l’IA fornendole dati già etichettati (ad esempio: “questa è l’immagine di un cane”, “questa di un gatto”). È il metodo più comune, usato per classificare e-mail, riconoscere volti o prevedere le vendite.
- Apprendimento Non Supervisionato: Immagina di dare all’IA una cassa piena di frutta mista e dirle: “Organizza tu”. L’IA non sa cosa siano mele o banane, ma le raggruppa per colore, forma e dimensione. Questo approccio scopre schemi e gruppi nascosti in dati non etichettati ed è usato, ad esempio, per segmentare i clienti.
- Apprendimento per Rinforzo: L’IA impara attraverso tentativi ed errori. Compie un’azione e riceve una “ricompensa” (un punteggio positivo) se l’azione era corretta, o una “punizione” (un punteggio negativo) se era sbagliata, con l’obiettivo di massimizzare il punteggio. È la tecnica usata per insegnare alle IA a giocare o a controllare un braccio robotico.
Deep Learning: Insegnare all’IA a “Pensare” per Strati
All’interno del machine learning, una tecnica si è rivelata rivoluzionaria: il Deep Learning (apprendimento profondo). Si basa su sistemi chiamati “reti neurali artificiali”, ispirati alle connessioni del nostro cervello.
Immagina queste reti come una serie di strati di neuroni artificiali. Quando mostriamo un’immagine di un cane alla rete:
- Il primo strato non vede “un cane”, ma solo elementi semplicissimi: linee, curve, punti di luce.
- Il secondo strato impara a combinare queste linee per riconoscere forme più complesse: un occhio, un orecchio, un naso.
- Lo strato successivo mette insieme queste forme per riconoscere parti ancora più grandi, come un muso o una zampa.
- Infine, lo strato finale assembla tutte le parti e conclude: “Con un’alta probabilità, questo è un cane”.
Più strati ci sono (ecco perché si chiama “profondo” o deep), più complesse e astratte sono le idee che l’IA può “capire”. Questo approccio, sebbene teorizzato decenni prima, ha potuto concretizzarsi solo di recente grazie a due fattori chiave: l’enorme quantità di dati resa disponibile da Internet e la straordinaria potenza di calcolo delle moderne schede grafiche (GPU).
A questo proposito il momento di svolta definitivo è stato nel 2012, quando un’IA basata sul deep learning, AlexNet, dominò la competizione ImageNet, dimostrando una superiorità schiacciante e dando ufficialmente il via alla rivoluzione che stiamo vivendo.
L’intelligenza artificiale che abbiamo disponibile oggi
Grazie a questo metodo, oggi abbiamo le cosiddette IA Generative e i Modelli Linguistici di Grandi Dimensioni (LLM). In pratica, questi modelli hanno “letto” una fetta enorme di Internet: libri, articoli, conversazioni. Così facendo, non hanno solo imparato la grammatica, ma anche come le idee si collegano tra loro, gli stili di scrittura e persino come si ragiona.
La definiamo “Generativa“, perché è la situazione in cui l’IA può creare qualcosa di nuovo come scrivere un’e-mail, comporre una poesia, creare il testo per un post sui social o riassumere un lungo documento, partendo da una semplice richiesta testuale.
Dalla teoria allo strumento di lavoro
L’applicazione pratica di queste tecnologie, oggi si traduce in tantissime applicazioni pratiche, come ad esempio gli agenti IA specializzati, che sono capaci di svolgere numerosi compiti re far risparmiare tempo prezioso.
Un esempio concreto è “Guido IA” di GBsoftware S.p.A., un assistente virtuale progettato specificamente per commercialisti e studi. Questo strumento funziona come un esperto di normativa che orienta i professionisti tra la mole di leggi e circolari fornendo spiegazioni in pochi istanti. La sua affidabilità deriva dall’addestramento esclusivo su fonti istituzionali (MEF, AdE, Gazzetta Ufficiale), garantendo così risposte precise e liberando risorse del commercialista per attività a maggior valore, come la consulenza strategica al cliente.
Non più un Concetto Astratto, ma un Nuovo Compagno di Lavoro
Il viaggio dell’intelligenza artificiale è stato lungo: dall’idea di dare regole rigide a un computer, alla rivoluzione dell’imparare dagli esempi, fino alla capacità di creare e dialogare che vediamo oggi.
La vera novità è che questa incredibile potenza non è più riservata solo ai giganti della tecnologia. È diventata uno strumento accessibile per rendere il lavoro più semplice, veloce ed efficiente. L’IA si sta trasformando in un vero e proprio compagno di lavoro, pronto ad aiutarci a navigare nella complessità del lavoro quotidiano.