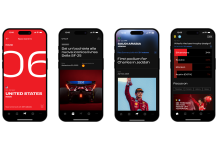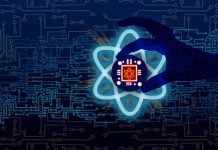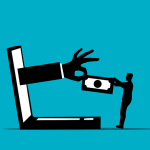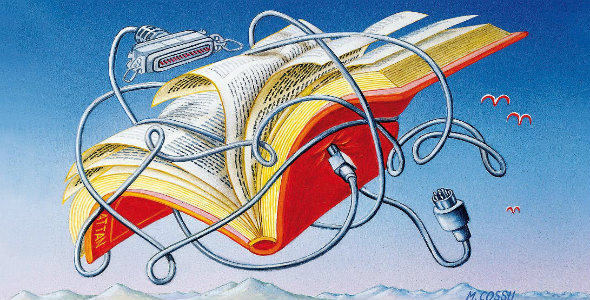
La parola competenza è ambigua e illusoria almeno quanto la parola innamoramento. Per entrambe è difficile dare una definizione, anche se, per la seconda parola, George Bernard Shaw in qualche modo l’ha fatto, definendo l’innamoramento un’esagerazione smisurata della differenza tra una persona e tutte le altre. Per le competenze, invece, la questione è più complicata. In primo luogo perché, a differenza dell’innamoramento, che proietta i fortunati in uno stato di grazia onirico totalmente estraneo al mondo reale, le competenze vengono esercitate in una cruda e superficiale realtà, oltre a essere valutate, misurate e giudicate da persone a volte assolutamente inadeguate. Inoltre, a differenza delle esagerazioni amorose, il divario di competenze può essere esageratamente smisurato tra una persona e tutte le altre. La misura, la valutazione e il giudizio, in realtà, vengono esercitati anche per i sentimenti, e questo la dice lunga sullo spessore culturale e morale di una società in cui ognuno si sente autorizzato a valutare, misurare e giudicare gli altri, rispetto a qualsiasi campo della conoscenza, con un rigore esagerato se confrontato con l’indulgenza che viene applicata verso sé stessi.
La PA, a differenza del settore privato, in cui gli addetti alla formazione e alla selezione del personale hanno un ruolo delicatissimo, utilizza dei meccanismi di selezione, di valutazione e di rilevazione dei fabbisogni formativi quantomeno bizzarri. Il titolo di studio, per esempio, l’antico italico pezzo di carta, quello che “un laureato conta più di un cantante”, per dirlo con le parole di Guccini, è considerato ancora il principale lasciapassare per l’accesso al concorso pubblico e alle carriere che “contano”. In più è, (o dovrebbe essere?) la prova provata delle competenze possedute dai candidati, che solleva le commissioni da qualsiasi responsabilità, liberandole dal gravoso compito di indagare sul percorso di vita che ciascun individuo ha intrapreso quando ha lasciato i banchi dell’università e che, probabilmente, lo ha arricchito almeno quanto il percorso di studi. Il ruolo di chi si occupa della formazione e della gestione delle risorse umane, quindi, è essenziale per l’adozione di percorsi mirati ad accrescere il set di competenze digitali dei lavoratori pubblici. È necessario conoscere a fondo i processi lavorativi, le tecnologie adottate e i singoli individui, per attuare misure realmente efficaci e spendibili dai lavoratori. C’è da dire che, molto frequentemente, le aree che si occupano di gestire le risorse umane di una pubblica amministrazione sono costituite da poche persone con le idee chiare, spesso arrese, sfiduciate e messe da parte, e da molte persone con le idee confuse, in cerca di visibilità, di gloria e di carriere, che probabilmente approdano all’ufficio del personale per sbaglio, per stanchezza o perché non hanno trovato una collocazione migliore.
Questo aspetto, laddove scarseggino le competenze umane e relazionali, rende l’applicazione di qualsiasi provvedimento riguardante le competenze digitali molto complesso. I dipendenti pubblici che acquisiscono nuove competenze, di qualsiasi tipo, dovrebbero avere dei benefici che non sempre sono evidenti. Benefici in termini di possibilità di crescita all’interno dell’organizzazione e di migliorie tangibili nello svolgimento del lavoro. Tutto ciò, in molte PA, non è possibile. Non è possibile perché la visione prospettica di ogni amministrazione pubblica è limitata dal perimetro istituzionale nel quale ci si muove. Non è possibile perché il meccanismo perverso attraverso il quale si costruiscono le carriere, la gloria e la visibilità nella Pubblica Amministrazione non è affatto associato al merito e alle competenze possedute, piuttosto viene costruito partendo dalla formalizzazione, sotto forma di delibere spendibili nei concorsi, di un qualche tipo di incarico, anche il più insignificante, di una qualche pubblicazione, anche la più insignificante, e dalla partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro, che adesso vengono chiamati più scenograficamente cabine di regia o task force. Insomma, fare carriera è un vero e proprio lavoro nel lavoro che assorbe quasi tutte le energie dei lavoratori. Le aspettative riposte nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), quindi, sono subordinate al (mal)funzionamento di una macchina con pochi ingranaggi giusti che vengono fatti funzionare nel modo sbagliato e molti ingranaggi sbagliati che funzionano in modo sbagliato. La mancanza di competenze digitali non è soltanto associata alla velocità con cui si muove la tecnologia e all’incapacità dei lavoratori pubblici di inseguirne i cambiamenti, ma è frutto di un sistema che negli anni ha disinvestito nella cultura e nella condivisione, favorendo l’individualismo e la competizione. In una recente intervista, il Ministro per l’innovazione e la transizione digitale Vittorio Colao ha rilasciato la seguente dichiarazione. “Sappiamo tutti che non c’è vera innovazione senza profonde competenze: mancando queste gli investimenti non possono decollare, la modernizzazione della PA rimarrà al palo, il sistema educativo non può diventare un motore di promozione sociale. Vogliamo innanzitutto colmare il gap digitale e competitivo tra Italia in Europa, grazie a un cambiamento culturale profondo di metodo. Occorrono investimenti, nuovi processi nella pubblica amministrazione, ma soprattutto competenze”.
Non è esatto. Dovremmo sapere tutti che non c’è vera innovazione se non c’è una profonda cultura condivisa. I cambiamenti di qualsiasi tipo, anche quelli peggiorativi, hanno sempre una solida base culturale. Le competenze sono una conseguenza di un percorso culturale che la formazione può soltanto perfezionare. Per cambiare realmente il lavoro pubblico è necessario cambiare la cultura del lavoro, valorizzando adeguatamente le risorse umane, a partire dalla dirigenza. La Pubblica Amministrazione è composta da diverse anime molto diverse tra loro. Ci sono alcune eccellenze, grandi e piccole, in cui il livello culturale è altissimo e molte amministrazioni paludose in cui rilevare i fabbisogni formativi è complesso a causa di processi organizzativi lacunosi, infrastrutture inadeguate e scarsa visione da parte dei vertici. Qualche anno fa, ingenuamente, avevo maturato la convinzione che per colmare i gap cognitivi digitali e rilevare i fabbisogni formativi nella PA fosse sufficiente applicare due modelli di rappresentazione delle competenze, Syllabus ed ECF 3.0, per misurare il livello e pianificare la formazione. Entrambi i modelli propongono un sistema di misura attraverso la rilevazione di alcune dimensioni che possono rappresentare il livello delle competenze digitali dei lavoratori pubblici. Le dimensioni possono far riferimento all’autonomia, alla complessità dei compiti svolti, ai comportamenti o al dominio cognitivo degli individui. Attraverso la combinazione di queste componenti, è possibile valutare il set di competenze digitali di base e specialistiche e attuare le politiche di formazione digitale più adeguate. Questo in teoria. In pratica, quando mi sono trovato a insegnare ai lavoratori delle amministrazioni pubbliche “come si fa”, ho capito meglio l’impossibilità di applicare metodi scientifici generalizzati. In primo luogo perché per effettuare una qualsiasi misura bisogna aver chiaro cosa si deve misurare e come. In un’istituzione di qualche centinaio di dipendenti, esistono:
- aree diverse (amministrative, produttive e tecnologiche)
- tecnologie diverse
- processi diversi
- organizzazioni del lavoro diverse
- esperienze personali diverse
- generazioni diverse
- volontà diverse
- motivazioni diverse
- interessi diversi
- culture (e subculture) diverse
- punti di vista diversi
- dirigenti diversi
Insomma, la parola più rappresentativa della pubblica amministrazione non è “digitale” ma “diversità”. Propagandare una qualche pozione magica che trasformi, seppur in un PNRR ben fatto, la parola diversità in digitale è pura demagogia. Per attuare un piano di formazione digitale nella PA è necessario procedere in una duplice direzione: da una parte ci sono le diversità e le necessità di competenze digitali specifiche per i singoli individui, dall’altra c’è la cultura digitale collettiva. E le due cose seguono canali totalmente distinti; :un conto è creare il tessuto di una nuova cultura, un altro conto è formare una risorsa all’uso di un foglio di calcolo o alla configurazione di un firewall. Ogniqualvolta ho indossato i panni da docente, queste due necessità sono emerse prepotentemente: i lavoratori vogliono conoscere il lessico, le tecnologie e le possibilità offerte dalla trasformazione digitale, ma per condurre con maggiore efficacia il lavoro quotidiano hanno bisogno di corsi specifici. Corsi che nella stragrande maggioranza dei casi si riferiscono non a un “digitale generico”, ma a temi specifici funzionali alle scelte tecnologiche e organizzative dell’amministrazione. Purtroppo, l’intreccio generazionale non aiuta molto a sciogliere questi nodi. La forza lavoro prossima alla pensione è spesso disinteressata alle opportunità di crescita, mentre le nuove generazioni hanno competenze digitali più legate all’uso dei dispositivi e delle applicazioni social che non ai prodotti, ai metodi e ai linguaggi del mondo digitale. I giovani, insieme alle fasce di lavoratori di mezza età, molto spesso apprendono sul campo le competenze necessarie allo svolgimento del lavoro, a volte vengono addirittura formate attraverso corsi che non hanno un’applicabilità alle attività quotidiane e che rappresentano più che altro una perdita di tempo e di energie. È proprio dalla diversità accennata nelle righe precedenti che bisogna partire per affrontare la sfida del digitale. In questo, possono essere d’aiuto le famose regole delle 5W, derivanti dal giornalismo anglosassone, quantomeno per suddividere una pubblica amministrazione in sottoinsiemi omogenei e pianificare una formazione mirata. Chi sono i dipendenti pubblici? Che tipo di attività svolgono? Dove lavorano principalmente? Quando svolgono la loro attività lavorativa? Perché hanno bisogno di acquisire competenze digitali? Rispondere a queste domande significa conoscere a fondo il capitale umano e la collocazione dei lavoratori all’interno della PA. E la conoscenza è la base di qualsiasi tipo di competenza, anche di quella dei decisori.
A cura di Alessandro Capezzuoli, funzionario ISTAT e responsabile osservatorio dati professioni e competenze Aidr