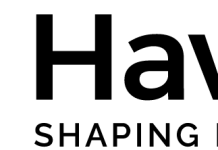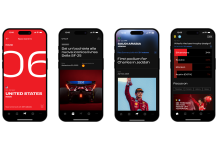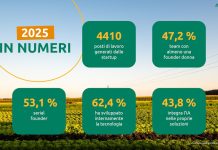Nell’articolo che condividiamo di seguito, Andrea Zinno, Data Evangelist di Denodo, realtà specializzata nella gestione dati, parla dello European Data Act (EDA), che entrerà in vigore il 12 settembre 2025, e delle architetture logiche dei dati che possono contribuire a ridefinire l’approccio alla gestione dei dati.
Il nuovo Data Act mira a garantire un accesso più equo, sicuro, trasparente e sostenibile ai dati; tuttavia, per realizzare concretamente questa visione, è necessaria una profonda revisione dell’approccio attuale, oggi frammentato, poco accessibile e scarsamente governato.
Come sottolinea infine Andrea Zinno, l’European Data Act non è solo una norma, ma un’opportunità per costruire un ecosistema digitale più equo e trasparente, dove il dato diventa un asset strategico al servizio dell’innovazione, della competitività e del bene comune.
Buona lettura!
European Data Act: come le architetture logiche possono favorire una governance dei dati equa, resiliente e condivisa
Lo European Data Act (EDA), adottato dall’Unione Europea all’interno di una più ampia strategia per la creazione un mercato unico digitale, rappresenta un cambiamento epocale nel modo in cui i dati vengono trattati, scambiati e valorizzati all’interno dell’UE. Il regolamento, che entrerà definitivamente in vigore il 12 settembre 2025, mira, infatti, a garantire un accesso più equo, sicuro, trasparente e sostenibile ai dati generati da dispositivi connessi, promuovendone la condivisione tra imprese, cittadini e istituzioni pubbliche. Il nuovo framework normativo non è però sufficiente a concretizzare questa visione: è necessaria anche una profonda revisione dell’approccio stesso alla gestione dei dati, oggi troppo frammentato, poco accessibile e scarsamente governato.
Un nuovo paradigma per la gestione dei dati
L’European Data Act introduce diritti e obblighi in materia di accesso, interoperabilità, condivisione e portabilità dei dati tra attori pubblici e privati. Le organizzazioni devono quindi adottare modelli tecnologici capaci di rispondere a queste esigenze, abilitando una gestione dei dati flessibile, scalabile e resiliente. In questo contesto, le architetture logiche dei dati si affermano come soluzione ideale: permettono di integrare dati da fonti differenti senza duplicarli, mantenendo la sovranità informativa e semplificando la governance. A differenza dei modelli tradizionali basati sul paradigma ETL (Extract, Transform, Load), le architetture logiche si fondano su un principio di virtualizzazione e connessione diretta alle fonti. Questo approccio consente di unificare i dati mantenendo intatta la loro posizione originale, riducendo i costi di replica e migliorando la sicurezza.
L’importanza del modello semantico
Al centro delle architetture logiche vi è il modello semantico, che realizza la concettualizzazione del contesto di riferimento e la mette a disposizione di tutti, in modo chiaro, coerente e non ambiguo, arricchendo i dati di tutti quegli elementi (o meglio, meta-elementi) che sono funzionali a una loro corretta individuazione, comprensione e applicazione. Questo modello facilita quindi l’uso dei dati da parte di utenti con competenze differenti, oltre ad armonizzare le informazioni provenienti da diverse fonti. Inoltre, permette di definire regole di accesso e visibilità, garantendo conformità alle normative sulla privacy e rafforzando la fiducia tra gli stakeholder. Il modello semantico funge anche da ponte tra la componente tecnica e quella di business, consentendo una rappresentazione dei dati che sia al tempo stesso rigorosa e comprensibile. È qui che si realizza la vera democratizzazione del dato: quando ogni utente può accedere, comprendere e utilizzare le informazioni in modo autonomo e responsabile.
Democratizzazione e accessibilità
La democratizzazione dei dati è un principio cardine dell’European Data Act: le architetture logiche possono contribuire a concretizzarlo, attraverso strumenti come i Data Catalog, che offrono un punto di accesso ai dati pensato specificatamente per i Data Consumer, non solo semplificando tutte le attività di esplorazione dei dati, ma abilitando la connessione tra significato dei dati e loro occorrenze. Questo approccio riduce le barriere tecniche, favorisce l’autonomia degli utenti e stimola una cultura data-driven, dove il dato diventa patrimonio condiviso e motore di innovazione. In un’organizzazione realmente data-driven, i dati non sono infatti più dominio esclusivo di analisti e tecnici, ma diventano accessibili a tutti i livelli. Questo favorisce la collaborazione tra le diverse funzioni aziendali, accelera i processi decisionali e stimola lo sviluppo di nuovi modelli di business basati sulla condivisione e sull’intelligenza collettiva.
Resilienza tecnologica e continuità operativa
Un altro vantaggio abilitato dalle architetture logiche per l’integrazione dei dati è la resilienza: separando l’accesso ai dati dai livelli fisici di storage e tecnologici sottostanti, creano un’astrazione flessibile che consente alle organizzazioni di evolvere le proprie infrastrutture senza interrompere l’esperienza del Data Consumer. Migrazioni, aggiornamenti o cambiamenti tecnologici avvengono in modo trasparente, preservando la continuità operativa e semplificando l’adattamento ai nuovi paradigmi digitali: le organizzazioni possono così evolvere tecnologicamente senza inficiare sulle operazioni quotidiane o sui flussi di lavoro degli utenti, che continuano ad accedere ai dati e a utilizzarli senza soluzione di continuità.
Il ruolo dell’intelligenza artificiale
Al pari dei Data Consumer, anche l’intelligenza artificiale utilizza i dati per le proprie elaborazioni. L’integrazione con l’intelligenza artificiale, sia tradizionale che generativa, è quindi facilitata dalla disponibilità di dati ben modellati e governati. In particolare, affinché i sistemi basati sulla Retrieval Augmented Generation (RAG) possano associare correttamente gli elementi linguistici di una query in linguaggio naturale ai dati sottostanti, devono comprendere non solo i valori dei dati, ma anche il loro significato e il contesto al quale si riferiscono. Questa comprensione si basa su metadati ricchi e ben strutturati, che definiscono, con una terminologia vicina al business, le relazioni, le gerarchie e il significato dei dati. Le Logical Data Architecture sono ideali per fornire questi metadati attraverso i propri modelli semantici. In parallelo, la stessa AI può inoltre supportare la gestione dei dati, automatizzando attività come la classificazione, la validazione e il monitoraggio della qualità. Questo riduce il carico di lavoro dei data steward e migliora l’efficienza complessiva del sistema informativo.
Le raccomandazioni da seguire
Lo European Data Act non è solo una norma, ma un’opportunità per costruire un ecosistema digitale più equo, trasparente e sostenibile. Questo a patto che le organizzazioni si pongano in condizione non solo di garantire la conformità al Data Act, ma anche di trasformare il dato in un asset strategico al servizio dell’innovazione, della competitività e del bene comune. Come fare?
- Adottando architetture logiche dei dati per separare l’accesso dai vincoli fisici e abilitare l’integrazione distribuita nel rispetto delle norme dell’European Data Act.
- Costruendo un modello semantico attivo per armonizzare significato e utilizzo dei dati provenienti da attori differenti.
- Centralizzando la governance dei dati a livello logico per gestire accessi, mascheramenti e conformità in modo scalabile e indipendente.
- Abilitando la democratizzazione dei dati attraverso strumenti di Data Catalog e Data Marketplace, consentendo un uso responsabile e diffuso del patrimonio informativo.
- Supportando AI e RAG con dati contestualizzati e strutturati logicamente, per migliorare l’efficacia degli assistenti virtuali e delle decisioni automatizzate.
- Promuovendo hub locali o settoriali per federare dati e semplificare l’adozione del Data Act da parte delle aziende più piccole e con scarse competenze tecnologiche.
di Andrea Zinno, Data Evangelist di Denodo