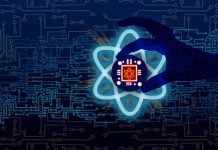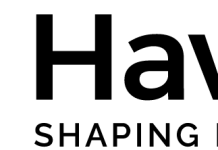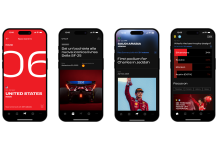Di seguito condividiamo un articolo di Alessandro Brizzi, General Manager di Renovis, Energy Service Company che propone e realizza soluzioni per l’efficienza energetica, destinate prevalentemente all’industria. L’autore si sofferma sul tema dei cosiddetti settori “hard-to-abate” e sul potenziale dell’idrogeno verde come leva strategica per la transizione energetica e la competitività delle imprese.
Buona lettura!
Settori hard-to-abate e il ruolo dell’idrogeno verde, facciamo il punto
A partire dal Protocollo di Kyoto del 1997, negli ultimi anni la sostenibilità ambientale, al centro delle successive conferenze sul clima, è diventata un criterio essenziale nelle decisioni politiche e industriali. La ventunesima riunione della Conferenza delle parti (Cop 21) della Convenzione sui cambiamenti climatici, tenutasi a Parigi nel dicembre 2015, ha sancito un ulteriore cambio di passo: l’Accordo di Parigi, sottoscritto da 177 Stati, impegna a mantenere l’aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 °C e, se possibile, entro 1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali.
Da allora, soprattutto nel contesto europeo, complice anche il crescente peso esercitato dall’opinione pubblica – in particolare giovanile – sulle tematiche ambientali, si è affermata una politica verde e sensibile al tema della sostenibilità sociale ed ambientale. Due esempi su tutti: da un lato il Green Deal Europeo, varato dalla Commissione guidata da Ursula von der Leyen nel 2019, che definisce un piano per riconvertire l’economia in chiave sostenibile; dall’altro, l’European Climate Law, che traduce in legge l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, fissando al contempo il traguardo intermedio di una riduzione delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030 rispetto al 1990. Nel complesso, questi provvedimenti mirano a garantire che tutte le politiche dell’UE contribuiscano alla sostenibilità e che ogni settore dell’economia faccia la propria parte.
È in questo scenario che la decarbonizzazione dell’industria assume un ruolo strategico, soprattutto nei settori dove intervenire è più difficile: i cosiddetti settori hard-to-abate. Si tratta di comparti – come, ad esempio, la siderurgia o la chimica pesante – ad alta intensità energetica e responsabili di elevate emissioni di CO2, per i quali sono necessari investimenti mirati in tecnologie in grado di decarbonizzare prodotti e processi.
I dati parlano chiaro. Stando a quanto emerge da una ricerca realizzata dall’Energy&Strategy – School of Management Politecnico di Milano nel solo 2023 i settori industriali hard-to-abate sono stati responsabili nel 2023 dell’11% delle emissioni italiane e del 13% di quelle europee. Inoltre, secondo il report realizzato da Allianz Trade, in Europa quattro delle industrie più difficili da decarbonizzare – acciaio, cemento, alluminio e ammoniaca – generano da sole il 7,7% dei consumi energetici e circa il 9,7% delle emissioni totali su suolo europeo. In Italia, nel 2022, le emissioni dei settori hard-to-abate hanno raggiunto i 67 MtCO₂, contro i 22 MtCO₂ degli altri comparti industriali.
Nonostante gli innumerevoli sforzi di efficientamento energetico, la riduzione del loro impatto climatico procede lentamente, vista anche l’insostenibilità dal punto di vista economico. Ciò in ragione del fatto che le emissioni non dipendono solo dai combustibili utilizzati, ma dai processi produttivi stessi, estremamente complessi da riconvertire e, soprattutto, difficili da riprogettare.
Di conseguenza, in molti casi la risposta più immediata ai settori hard-to-abate dipende dalla disponibilità di energia rinnovabile, da nuove tecnologie a supporto dei processi industriali e da meccanismi di protezione della competitività europea, come ad esempio il Carbon Border Adjustment Mechanism, ritenuti essenziali per attrarre gli investimenti necessari alla transizione.
Tra le soluzioni che possono accelerare la decarbonizzazione dei settori hard-to-abate, un ruolo sempre più rilevante è assegnato all’idrogeno verde, la forma di idrogeno a più basse emissioni, prodotta tramite elettrolisi alimentata da fonti rinnovabili. Tuttavia, secondo quanto emerge dal The European hydrogen market landscape realizzato nel novembre 2024, l’idrogeno a basse emissioni di carbonio rappresenta una quota ancora marginale del mercato europeo: solo lo 0,34% della domanda complessiva di idrogeno. La sfida è dunque quella di promuovere la trasformazione di un sistema ancora fortemente dipendente dall’idrogeno di origine fossile verso soluzioni pienamente sostenibili. Da questo punto di vista, le prospettive di crescita mostrano segnali incoraggianti. La domanda europea di idrogeno potrebbe salire fino a 45,5 Mt entro il 2050, con una crescente diffusione nell’industria pesante e nei trasporti, che, stando alle stime, nel 2050 rappresenteranno ciascuno il 37% del consumo totale. Il fattore determinante resta, ancora una volta, quello dei costi: l’H₂ verde prodotto da elettrolisi alimentata da rinnovabili si colloca oggi attorno ai 6,61 €/kg, contro i 3,76 €/kg dell’idrogeno fossile. Per essere competitivo negli usi industriali, il costo dovrà scendere verso una fascia 2,5–5,8 €/kg, a seconda del settore applicativo.
In sintesi, nonostante l’indubbio ruolo strategico, l’adozione dell’idrogeno verde nei settori hard-to-abate in Italia e in Europa è dunque ancora lontana dall’essere finalizzata. Questo in ragione di tre ostacoli principali. Il primo ostacolo riguarda il già citato tema dei costi: produrre idrogeno rinnovabile richiede grandi quantità di energia pulita a un prezzo competitivo. A tal proposito, ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – attesta come nel 2024 il prezzo medio dell’energia elettrica in Italia (PUN) sia stato di 108 €/MWh, in calo del 15% rispetto al 2023, sebbene nell’ultimo trimestre sia risalito a 127 €/MWh a causa dell’aumento del prezzo del gas e della minore produzione da fonti rinnovabili.
Rispetto agli altri Paesi europei, l’Italia resta comunque il mercato più costoso in assoluto: nello stesso periodo il prezzo medio dell’elettricità è stato di circa 91 €/MWh in Germania, 78 €/MWh in Francia e 79 €/MWh in Spagna, con un differenziale di 20–30 €/MWh che gioca a sfavore di un Paese ancora fortemente dipendente dalla generazione termoelettrica a gas. Inoltre, nel confronto di lungo periodo, i prezzi italiani risultano più che raddoppiati (+110%) rispetto alla media 2010–2021, segno che i livelli attuali di costo sono diventati strutturalmente più elevati. Una condizione che, nel complesso, incide direttamente sulla competitività dei settori energivori – come siderurgia, cemento e chimica di base – e rende quindi più complessa la transizione verso l’idrogeno verde.
Il secondo nodo da sciogliere riguarda la questione delle infrastrutture. Elettrolizzatori, reti dedicate, impianti di stoccaggio: l’espansione della filiera procede lentamente e molti progetti, sia in Europa sia in Italia – sebbene sostenuti dai corposi finanziamenti del PNRR – sono ancora nella fase iniziale. A frenare ulteriormente la transizione contribuisce il mercato, tuttora fragile, reso incerto dalle recenti turbolenze geopolitiche che impattano pesantemente sul settore energetico e sulla fiducia generale degli investitori.
Da non trascurare, poi, il tema della cattiva allocazione delle risorse europee disponibili destinate alla decarbonizzazione. È il caso, ad esempio, dell’European Innovation Fund, principale programma dell’Unione Europea per promuovere lo sviluppo e l’adozione di tecnologie e processi innovativi per la decarbonizzazione dell’industria. A ottobre 2024, il fondo aveva destinato ai Paesi europei 7,42 miliardi di euro, di cui il 54% ai settori hard-to-abate. Tuttavia, solo il 2% dei fondi è associato a progetti sviluppati in Italia, contro il 12% della Germania, l’11% della Spagna e il 7% della Francia. Un divario che conferma come l’Italia, pur avendo un tessuto industriale energivoro, mostri delle difficoltà nel tradurre in progetti concreti le risorse europee disponibili.
In un quadro normativo frammentato, emerge, infine, anche la concorrenza di soluzioni low-carbon alternative – come la cattura e lo stoccaggio della CO₂ o il cosiddetto idrogeno “blu” – che rappresentano sicuramente scelte meno rischiose per l’industria. In questo modo, anche se il potenziale dell’idrogeno verde è enorme, senza un investimento simultaneo su costi, infrastrutture, domanda e politiche industriali, il suo apporto rischia di rimanere inespresso.
di Alessandro Brizzi, General Manager di Renovis